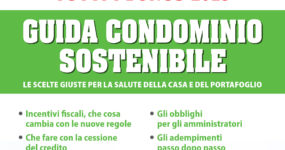Adeguamento energetico degli edifici: come bilanciare involucro e impianti

Involucro e impianti, sistemi passivi e sistemi attivi: l’adeguamento energetico degli edifici è molto spesso il frutto di un corretto bilanciamento di più variabili. Non esiste una soluzione per tutte le situazioni, piuttosto una corretta scelta tra le molteplici tecniche disponibili, in funzione degli obiettivi da perseguire.
Il tema dell’energia è un nodo fondamentale dei nostri tempi e lo sarà con tutta probabilità nei decenni a venire. Da un lato, la maggior consapevolezza di un necessario cambiamento di modello di sviluppo, rispetto a quello basato sulle fonti non rinnovabili che, in quanto tali, sono destinate ad aumentare il loro valore in maniera inversamente proporzionale alla loro diponibilità sul mercato, incrementando sempre di più i costi per gli utenti finali; dall’altro una differente sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali, che ha determinato un avvicinamento generalizzato ai concetti di “energia pulita” e “sostenibilità”.
Questi due aspetti hanno pesantemente influenzato in tempi recenti il nostro modo di pensare comune, riflettendosi su tutti i settori della nostra economia, non da ultimo l’edilizia.
L’industria delle costruzioni è uno dei settori produttivi più importanti da un punto di vista economico: l’indotto che ruota attorno ad essa in termini di materiali, attrezzature e forza lavoro ha pochi pari.
Un processo produttivo che si avvale di componenti semilavorati che consumano energia per essere creati e che ne consumano un’ulteriore quantità per essere assemblati o messi in opera in cantiere.
Il suo prodotto inoltre (gli edifici, di qualsiasi destinazione d’uso) è esso stesso un’entità che, durante tutto il suo ciclo di vita utile, consuma energia e lo fa generalmente in maniera non costante: incrementando cioè i propri consumi con il passare degli anni, quando l’efficienza delle sue componenti tende a una naturale decrescita.
Il binomio energia – costruzioni
È facile comprendere, quindi, come il tema dell’energia occupi un posto davvero rilevante quando si parla di costruzioni e sapere come e dove intervenire per ottimizzarne l’utilizzo è una capacità che fa la differenza in mercati così competitivi come il nostro.
Se la riduzione dei consumi nel processo produttivo che porta alla realizzazione di un edificio è un obiettivo molto ambizioso, che coinvolge non solo il mondo delle costruzioni ma intere filiere manifatturiere (pensiamo al progetto “Cantiere Sostenibile” messo in campo da Ance), oggi ci concentreremo piuttosto su metodi e tecnologie finalizzate all’adeguamento e al contenimento energetico del prodotto finito: gli edifici.
Quando si parla di energia in un edificio, prodotta o consumata, o più genericamente di fabbisogno energetico di un edificio, ci si deve sostanzialmente focalizzare su due aspetti fondamentali: involucro e impianti.
Involucro
L’involucro è quell’insieme di elementi tecnologici che proteggono e definiscono da un punto di vista spaziale l’interno di un edificio dall’esterno e che, nel contempo, contribuiscono a creare le condizioni ideali di benessere abitativo in funzione delle condizioni climatiche che si verificano all’esterno (temperatura, rumore, vento). L’involucro è in pratica una sorta di barriera che si frappone tra lo spazio abitato e il mondo esterno.
Proprio il concetto di barriera ci porta a individuare l’involucro edilizio come quell’insieme di soluzioni passive che contribuiscono a contenere il fabbisogno energetico di un edificio.
In tal senso, tra le principali soluzioni adottate per l’adeguamento energetico di un edificio possiamo individuare:
- Isolamento a cappotto esterno: è la metodologia attualmente più utilizzata sia nelle nuove costruzioni, sia negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Prevede l’applicazione di un materiale isolante, generalmente sotto forma di pannelli rigidi, sulla faccia esterna della muratura perimetrale di un edificio. Il tutto viene poi completato con una doppia rasatura cementizia con interposta rete antifessurazione e intonachino di finitura. I materiali isolanti più utilizzati sono l’Eps (polistirene espanso), la lana di roccia o la fibra di legno. Vantaggio principale del cappotto esterno è l’uniformità della coibentazione che viene applicata; particolare attenzione deve però essere riservata a eventuali fenomeni di condensa interstiziale nelle murature.
- Isolamento a cappotto interno: laddove intervenire in facciata non sia consentito per motivi architettonici o di regolamentazione normativa, è possibile intervenire dall’interno. Il sistema a cappotto interno consiste nella placcatura del lato interno delle murature perimetrali con materiale isolante. In questi casi un fattore importante è anche la resistenza meccanica superficiale del pacchetto di isolamento, per questo la metodologia più utilizzata è quella delle contropareti coibentate (generalmente lana di roccia) con finitura in lastra di cartongesso.
- Insufflaggio: applicazione di materiale coibente sfuso (fibra di vetro in fiocchi, poliuretano) nell’intercapedine di paramenti murari a doppia camera oppure sull’estradosso di solai di sottotetti non accessibili o comunque non abitabili.
- Facciata ventilata: è una tecnica simile al cappotto esterno dove l’isolamento è sempre applicato al lato esterno della muratura perimetrale, ma viene poi nascosto da un rivestimento ancorato ad una sottostruttura metallica che crea un’intercapedine naturalmente ventilata tra isolamento e rivestimento di facciata. Oltre alla grande libertà architettonico/compositiva, il rivestimento può essere scelto tra svariati materiali (ceramica, laterizio, alluminio): il vantaggio di questo sistema, benché abbastanza costoso, è di garantire un buon apporto in termini di contenimento energetico nel doppio ciclo invernale/estivo, proprio grazie alla ventilazione naturale.
Nel caso di nuove costruzioni, elevati livelli di contenimento energetico raggiunti grazie all’apporto dell’involucro edilizio possono essere raggiunti con la scelta di pacchetti murari particolarmente performanti (blocchi di calcestruzzo autoclavato, sistemi stratificati a secco, ecc.).
Coperture
Allo stesso modo è opportuno non dimenticare come anche le coperture sono una parte fondamentale dell’involucro, siano esse piane o inclinate. Per le coperture in pendenza, la soluzione del tetto ventilato è sempre la più consigliabile: del tutto simile ad una facciata ventilata, fonda il proprio principio di funzionamento sull’intercapedine ventilata che si crea tra manto di copertura e pacchetto d’isolamento.
In ogni caso, quando si parla di coperture, la scelta dell’isolante dev’essere sempre fatta con particolare attenzione al fattore irraggiamento solare, essendo le stesse molto esposte, e quindi al conseguente fenomeno dello sfasamento termico.
Impianti
Gli impianti tecnologici sono quell’insieme di dispositivi che forniscono un apporto attivo nella creazione di un determinato comfort abitativo degli spazi interni.
Se mediante l’involucro, infatti, in un certo senso definiamo volumetricamente uno spazio, delineandone il perimetro e quindi automaticamente determinandone una condizione climatica differente rispetto al mondo esterno, con gli impianti tecnologici interveniamo in maniera diretta nella termoregolazione degli ambienti abitati, arrivando a definirne i parametri fin nei minimi dettagli.
È evidente come involucro e impianti siano elementi tra di loro complementari, che non possono prescindere uno dall’altro: il corretto bilanciamento di queste due componenti è la chiave per il raggiungimento di un’efficienza energetica di buon livello a fronte di costi di costruzione e di gestione sostenibili.
Quando parliamo di impianti tecnologici in ambito di adeguamento energetico degli edifici, il primo pensiero corre automaticamente al riscaldamento degli ambienti nella stagione invernale.
La tendenza più diffusa, un po’ come in altri settori produttivi, è l’elettrificazione dei processi: l’utilizzo di pompe di calore, in grado anche di gestire anche i cicli di climatizzazione estiva è ormai sempre più diffuso.
Le maggiori limitazioni di questi sistemi sono date dallo scarso rendimento in presenza di temperature molto rigide: proprio per questo, la soluzione più efficace è in molti casi rappresentata da generatori di calore ibridi, che uniscono la sostenibilità dell’elettrico all’immediatezza di risposta del gas metano.
Fondamentalmente, quest’ultimo agisce principalmente da backup del sistema elettrico, nelle situazioni in cui l’efficienza delle prime tende a diminuire.
Nelle nuove costruzioni, così come negli interventi sul costruito, la metodologia di riscaldamento maggiormente diffusa è del tipo a pavimento radiante: l’omogeneità del calore trasmesso e percepito è divenuta ormai insostituibile rispetto ai tradizionali radiatori puntuali.
Talvolta si ricorre anche al ciclo inverso di raffrescamento, che però deve essere attentamente studiato, in particolar modo in riferimento alla gestione della deumidificazione degli ambienti.
Al di là della tematica caldo/freddo, l’adeguamento energetico di un edificio passa sempre attraverso un’analisi energetica che metta in evidenza i punti critici e i fattori di miglioramento: il fine ultimo è sempre il contenimento dei consumi.
Fotovoltaico
Non sorprende, quindi, la sempre maggior diffusione di impianti fotovoltaici, anche per uso domestico. La grande differenza in questo senso potrebbero farla le Comunità Energetiche Rinnovabili.
Nate sulla scorta delle direttive Ue in materia di sostenibilità energetica, si propongono come dei soggetti giuridici a cui fanno capo impianti delocalizzati in grado di produrre determinate quantità di energia elettrica che viene messa a diposizione per il fabbisogno locale.
L’adesione, come privato cittadino o azienda, non presuppone la disponibilità diretta di un impianto ma consente l’affiliazione ai fini dell’utilizzo a tariffe agevolate di energia in surplus prodotta da altri impianti presenti nel territorio.
Si tratta di un approccio diverso, che potrebbe influire anche sulle pratiche operative di adeguamento energetico degli edifici: l’utilizzo di energia prodotta da una Cer, infatti, non implica alcun allacciamento fisico o installazione di qualsivoglia dispositivo essendo, infatti, un’operazione di carattere amministrativo.
La complementarità tra diverse tecnologie e soluzioni disponibili sul mercato è pertanto la migliore chiave per approcciare un processo di adeguamento energetico degli edifici, accettando la sfida per la sostenibilità che il mercato ci chiede sempre più insistentemente.
di Matteo Cazzaniga