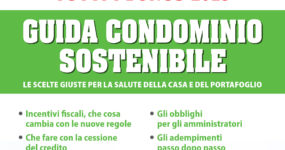Cappotto termico e vizi edilizi: gli obblighi dell’appaltatore

L’isolamento a cappotto termico migliora l’efficienza energetica degli edifici, ma la sua realizzazione deve seguire rigorose regole tecniche per evitare difetti e danni. L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare un’opera immune da vizi e difformità, garantendo la qualità del rivestimento.
I rivestimenti posti sulla facciata sono uno strato esterno che viene applicato sugli edifici per proteggerli dagli agenti atmosferici e migliorarne l’aspetto estetico.
Questi elementi svolgono un ruolo fondamentale nell’isolamento termico (ad esempio il cappotto termico, sistema di isolamento che permette di ottimizzare le prestazioni energetiche degli edifici) e acustico, contribuendo così al risparmio energetico e al comfort abitativo. I rivestimenti di facciata possono essere realizzati con molteplici materiali, ognuno con caratteristiche specifiche.
Responsabilità dell’appaltatore e garanzie di qualità
Nella realizzazione di questi elementi edili occorre procedere da parte dell’appaltatore con grande perizia e secondo le regole dell’arte. Il contratto di appalto, comunemente ricondotto nell’ambito della categoria dei contratti fonti di obbligazioni di risultato, determina il sorgere, in capo all’appaltatore, dell’obbligo di eseguire l’opera a esso commissionata, garantendo la realizzazione della stessa immune da vizi e difformità.
In tal senso, infatti, depone il disposto dell’art. 1667 c.c., a mente del quale “l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera” sia l’art. 1669 c.c., secondo il quale “L’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa”.
Sul punto la giurisprudenza ha aperto alla possibilità, per il danneggiato, di chiedere il risarcimento del danno derivante dalle difformità e dai vizi dell’opera commissionata, nella forma dunque del c.d. risarcimento per equivalente. Ritiene in particolare la giurisprudenza di legittimità che “nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell’opera, può richiedere, a norma dell’art. 1668, primo comma, cod. civ., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell’appaltare mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall’art. 2931 cod. civ., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi” (Cass. n. 6181/2011).
Applicando tale regola occorre evidenziare in primo luogo che la norma che viene in rilievo è principalmente quella di cui all’art. 1669 c.c. La norma in esame è ritenuta dalla giurisprudenza configurare un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sancita per finalità di interesse generale, come quelle della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici, e della incolumità personale dei cittadini (Cass. Civ., sent. n. 35931/2022; Cass. Civ., sent. n. 4319/2016; T. Milano 24.9.1990); inoltre introduce una presunzione iuris tantum di responsabilità, la quale può essere vinta dall’appaltatore con la prova dell’ascrivibilità del fatto al fortuito o all’opera di terzi (Cass. Civ., sent. n. 15488/2000).
Difetti e soluzioni per il ripristino
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell’affermare che i “gravi difetti” della costruzione non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell’edificio, poiché, in tal caso, finirebbero con l’identificarsi con l’ipotesi del “pericolo di rovina”; possono invece consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell’opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l’utilità cui è destinata.
E ciò indipendentemente dalla somma di denaro necessaria per la loro eliminazione (Cass. Civ., sent. n. 3752/2007): può dunque trattarsi di lesioni alle strutture, di imperfezioni o di difformità tali da diminuire sensibilmente il valore economico dell’edificio nel suo complesso, o di singole sue parti, senza che debba sussistere anche il pericolo di un crollo immediato (Cass. Civ., sent. n. 2977/1998), ovvero di alterazioni che attengano a quegli elementi, accessori o secondari, che consentono però l’impiego duraturo cui l’opera è destinata, (Cass. Civ., sent. n. 11740/2003), quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l’impianto di riscaldamento, la canna fumaria (Cass. Civ., sent. n. 11740/2003).
Analizzando, più nello specifico, la giurisprudenza sul punto, emerge come siano numerose le fattispecie nelle quali sono stati ravvisati i gravi difetti. Tra di esse il distacco di una notevole parte dell’intonaco esterno del fabbricato (Cass. Civ., sent. n. 10624/1996).
A tal proposito giova ricordare un caso recente di una sentenza del Tribunale di Spoleto n 610/2024, laddove la relazione peritale agli atti conferma la sussistenza dei vizi lamentati.
Si legge infatti nel suddetto elaborato che: “i fenomeni esterni all’unità immobiliare e presenti nelle facciate possono riassumersi in cavillature e fessurazioni all’intonaco-rasatura del cappotto termico di facciata, presenti in corrispondenza di aperture (soglie e architravi di porte e finestre) e lungo tutta la trama dei pannelli e delle tassellature sottostanti all’intonaco-rasatura stesso.
Tale fenomeno è presente su tutte e tre le facciate interessate dall’unità immobiliare. Per questo, è stato accertato che i suddetti vizi e difetti incidono sulla fruibilità e funzionalità dell’immobile nel seguente modo: “Esternamente all’unità immobiliare, le cavillature, fessurazioni e crepe, presenti negli intonaci rasature dei rivestimenti di facciata, inibiscono il venir meno della funzione impermeabilizzante dell’intonaco, costituendo punti d’ingresso per eventuali infiltrazioni d’acqua.
Esternamente all’unità immobiliare, i vizi relativi al rivestimento termico del cappotto di facciata e al timpano di copertura potrebbero incidere sulla funzionalità isolante e certificata in “classe energetica A”.
Internamente all’unità immobiliare, si sono riscontrate la presenza di efflorescenze con macchie ed è stato accertato che la causa dei suddetti vizi è ascrivibile all’opera realizzata dalla ditta appaltatrice. In particolare:
- per eliminare l’insorgenza di umidità all’interno dell’abitazione, si dovrà realizzare correttamente l’impermeabilizzazione del giunto di attacco a terra parete-marciapiede, eseguendo l’impermeabilizzazione dietro al cappotto, anziché davanti;
- per eliminare l’insorgenza di cavillature e fessurazioni agli intonaci-rasature dei cappotti, si dovrà, una volta rimosso tutto il rivestimento, analizzare la corretta applicazione del collante e della schiuma su tutti i pannelli;
- verificare poi, lo stato e la corretta realizzazione del supporto e intervenire con la tipologia di intervento, che in fase di verifica si riterrà più idonea;
- per eliminare la presenza di cavillature e fessurazioni agli intonaci-rasature dei pannelli in cemento rinforzato del “timpano” di copertura, si dovrà, non essendo in possesso di dettagli esecutivi, rimuovere tutto il rivestimento, verificare la tipologia costruttiva di realizzazione dello stesso, ed intervenire con la tipologia di intervento che in fase di verifica si riterrà più idonea.
Il costo totale di realizzazione degli interventi descritti è stato quantificato in una spesa variabile tra € 62.215,50 ed € 64.715,50 (iva e oneri di cassa esclusi) a carico della dell’appaltatore.
In un caso analogo presso il Tribunale di Lodi (sentenza n. 450/2020) il consulente tecnico ha attribuito la causa delle efflorescenze diffuse sulle parteti degli edifici “da un lato alla trasudazione delle murature umide (probabilmente i pannelli sono stati fissati sulla muratura esterna ancora umida), dall’altro dalla mancanza della finitura superficiale a spessore del tipo “colorata”, la quale per sua stessa definizione e composizione è antimuffa ed è la finitura necessaria a garantire la durabilità del sistema cappotto”.
Ciò premesso, i vizi riscontrati devono essere imputati alla ditta per non aver eseguito a regola d’arte. Come noto, in tema di contratto di appalto, l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte, osservando nell’esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176 co. 2 c.p.c. quale modello astratto di condotta che si estrinseca nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente e obiettivamente necessari o utili, in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell’interesse creditorio nonché ad evitare possibili eventi dannosi.
In ragione della specifica natura e della peculiarità dell’attività esercitata, l’appaltatore è quindi tenuto a comportarsi diligentemente, adottando le misure e le cautele necessarie e idonee per eseguire la prestazione, secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto richiesto idoneo a soddisfare l’interesse creditorio.
La prestazione dovuta dall’appaltatore implica, difatti, senza necessità di una specifica pattuizione, pure il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto (così Cass. Sent. n. 6754/2003 secondo la quale “l’appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d’arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l’errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente”).
L’appaltatore va invece esente da responsabilità laddove dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto come “nudus minister” per le insistenze del committente a rischio del medesimo. La ditta appaltatrice, in mancanza di prova in tal senso, veniva quindi condannata a risarcire i danni patiti pari al costo delle opere necessarie per l’eliminazione dei vizi quantificati in complessivi € 119.700,00.